Avanguardie e lingue iberiche degli anni Venti. A 100 anni dalla fondazione di “Vltra” (Madrid, 1921-1922), 04-05 novembre 2021
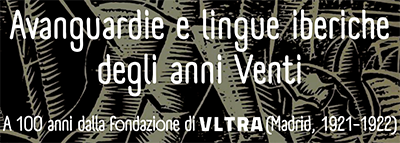
Varcate ormai le soglie del Centenario dell’Ultraismo (1919-2019), la prima avanguardia autoctona spagnola, pare utile mettere in luce il suo valore specifico all’interno della storia delle letterature iberiche e iberoamericane e confrontarlo, a livello comparatistico e interculturale, con altri movimenti d’avanguardia europei e mondiali della stessa epoca. La più originale tra le esperienze letterarie iberiche del primo Novecento, che si sviluppò dal 1919 al 1925, è stata a lungo trascurata dagli storici della letteratura per lo scarso valore poetico attribuito alla sua produzione. La mancanza di unità teorica e artistica e di un coerente sostrato ideologico, hanno spesso indotto a riflettere se nel caso del movimento ultraista si possa parlare d’avanguardia tout court. Il prefissoide greco del titolo (ultra-ismo = «oltre l’ismo o ismo dell’oltre») segnava la mera volontà di andare al di là di quanto esisteva allora nell’arte, oltre ogni sentimentalismo e oltre l’intelligenza, legando la poesia alla pura metafora o immagine. L’idea di andare oltre senza una meta precisa è un desiderio e, contemporaneamente, un imperativo categorico indiscriminato per i giovani poeti ultraisti. Parafrasando oggi il termine “ultraismo” si dovrebbe forse leggere: andare oltre l’unitarietà e lo spettro semantico dell’ismo abbracciando, inglobando e al contempo traducendo le idee e le modalità estetiche di tutti i movimenti europei d’avanguardia (gli ismi) che l’avevano preceduto cronologicamente.
Nella sua ricerca esasperata di novità e libertà dell’individuo in un mondo rinnovato dalla tecnica e nella sua filosofia vitalista che desiderava vivere, come ricorda Jorge Urrutia, «la vita e l’arte in modo originale», si rilevano gli elementi essenziali che permettono di includere l’Ultraismo entro il concetto di arte d’avanguardia. In esso sono presenti la maggior parte dei tratti distintivi della fenomenologia ben illustrata da Renato Poggioli: il momento attivistico («agire per il gusto d’agire» ); il momento antagonistico (operare contro il pubblico e contro la tradizione «nel senso d’una reazione negativa»); il momento nichilistico («raggiungere la non-azione attraverso l’azione, lavorare non per costruire ma per distruggere»); e infine il momento agonistico: l’autoimmolazione masochistica in nome del future generazioni. La nozione di «futurismo», inteso come «momento futuristico […] proprio a tutte le Avanguardie, e non esclusivo al movimento che assume quel nome», raccoglie in sé tutti i tratti sopra citati. Nell’Ultraismo possiamo infatti ritrovare uno stadio futuristico dell’arte, ovvero una fase profetica e utopistica di agitazione che pone le basi per le generazioni successive. In questo senso, gli ultraisti sono stati i precursori delle sperimentazioni non solo della Generazione del ’27, ma anche di tutti i successivi movimenti ispanici caratterizzati da una tensione di rinnovamento. Molti anni più tardi, il Postismo si ispirerà proprio alla prima avanguardia autoctona per il conio del nome.
Dagli anni Sessanta, in corrispondenza con la proliferazione delle neoavanguardie, si viene ormai rivalutando il movimento Ultra, non più considerato come uno sterile moto di rivolta, bensì come una tappa essenziale che lascerà un segno indelebile e una ricchissima eredità artistica alle generazioni successive. Da Guillermo di Torre in Spagna, che nel 1925 scriverà il primo saggio storico-critico sulle avanguardie europee (Literaturas europeas de vanguardia), ai poeti catalani come Joan Salvat Papasseit o Josep Maria Junoy che reagiranno personalmente ai “futurismi europei”, fino a Jorge Luis Borges, che nel giugno del 1920 esporta il movimento prima a Maiorca e poi a Buenos Aires, determinando la sua svolta culturale e criollista in Argentina, e generando movimenti affini come l’Estridentismo messicano. Il convegno vuole proporre un dibattito multidisciplinare sul tema del movimento ultraista all’interno delle letterature iberiche e ispano-americane. Dalla rivoluzione linguistica e ideologica dei vari manifesti letterari, allo studio dei testi poetici o in prosa densi di parole di nuovo conio (entrate in seguito a far parte del castellano standard), fino all’analisi delle riviste, dei testi audiovisivi dei primi anni Venti, si arriverà al dibattito intermediale e traduttologico pensato da una prospettiva semiotico-culturale, cercando di censire e riflettere sulle traduzioni di opere ultraiste condotte verso altre lingue come l’italiano, l’inglese, il portoghese o il francese.
Finalità e risultati attesi
Riflettere scientificamente sulla prima avanguardia autoctona ispanica all’interno delle letterature iberiche e iberoamericane nell’anno del Centenario della fondazione della rivista madrilena “Vltra” (Madrid, 1921-1922); confrontare, da una prospettiva comparatistica, il movimento ultraista con altre avanguardie internazionali per allargarne la conoscenza fra iberisti e comparatisti; censire le varie traduzioni di opere ultraiste verso altre lingue animando il dibattito traduttologico e interculturale; preparare una pubblicazione a partire dai materiali del convegno.
Comitato Scientifico Internazionale
Andrew A. Anderson, José María Barrera López, Juan Manuel Bonet, Daniele Corsi, Carlos García, Beatrice Garzelli, Alessandro Ghignoli, Llanos Gómez Menéndez, Giuseppe Grilli, Jorge Mojarro Romero, Gabriele Morelli, Cèlia Nadal Pasqual, Domingo Ródenas de Moya, Pablo Rojas.
Comitato organizzatore
Daniele Corsi, Viviana Gallón, Maria Eugenia Granata, Cèlia Nadal Pasqual, Javier Sanz Muro.
Informazioni
corsi@unistrasi.it
Iscrizioni
La partecipazione alle giornate è aperta e gratuita. È possibile partecipare in presenza o in modalità telematica.
Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/Vr5JdLE3XfdJ6ZJe6
Locandina
Programma